E’ il tradizionale
la rassegna di foto d’autore che ogni due anni arricchisce il panorama culturale della nostra Milano.
Più di un autore, più di un tema mi incuriosiscono, allora
mi rivolgo a Giancarlo, per tutti “Giazzi”. Lui è un fotografo di grande
passione, chi meglio di lui può aiutarmi a comprendere lo stile di un autore,
indirizzarmi verso una scelta piuttosto che un’altra?
Così, delle tre proposte che gli faccio per condividere un
giro a mostre, lui sceglie
The
Witness di
Max
Vadukul
Artista nato in Kenya da genitori indiani, collaboratore di
diverse riviste, predilige il bianco e nero, qui espone immagini col al centro
l’ambiente, i rifiuti urbani, gli effetti del cambiamento climatico.
Foto scattate in alcune metropoli indiane, particolarmente
afflitte dall’inquinamento.
Immagini molte belle, alcune mi emozionano. I giochi di
riflesso che ogni sfera presenta paiono un rimando alla nostra presenza: muta? Impotente?
O forse c’è ancora una possibilità di invertire la rotta che ci porta a
scapicollare verso il degrado della Madre Terra?
Usciamo soddisfatti dall’impatto estetico, molto meno dalle
riflessioni che quel degrado ci impone alla mente.
Un gran buon caffè al bar Zaini, nome storico (dal 1913)
per il cioccolato milanese, che, trasferitasi l’azienda fuori dalla città, qui
ha lasciato un paio di bar – pasticceria a deliziarci il palato. Lunghe
chiacchiere seduti su una panca in corso Como e due passi, sempre a
chiacchiere, nel quartiere Isola, totalmente rinnovato nell’architettura e
nell’urbanistica. Un bel pomeriggio, tra sole, amicizia e l’incontro con un
forte e autorevole rappresentante della fotografia contemporanea.
Fondazione Sozzani, corso Como 10
17.09.2022 – 08.01.2023
Le proposte del Photofestival
sono tante e variegate ma io opto per confrontarmi con
RI –
SCATTI
Ovvero:
Il carcere fotografato dai detenuti e dalla polizia penitenziaria
Un corso di fotografia rivolto ai detenuti ed agli agenti della polizia penitenziaria, quattro le carceri milanesi coinvolte, le opere poi dei detenuti stessi e delle guardie.
Ne esce una galleria di immagini decisamente particolari.
Molte belle, come possono essere “belle” delle fotografie ben scattate, qualcuna
che si distingue per taglio, visione, originalità. Alcune che mi emozionano
dentro, dentro mi turbano. Che sono davvero una spinta inarrestabile a
confrontarmi con l’Ombra che mi si agita dentro, con il terrore della fine di
ogni libertà, con la rottura, la separazione, inevitabile da un mondo che, a
noi “liberi”, è totalmente estraneo.
Mi par di notare una differenza tra le foto scattate dalle
detenute e quelle ad opera dei maschi: le prime più intime, più riflessive;
poi, tra i detenuti giovani e soprattutto stranieri, domina la fisicità, con
scatti di corpi muscolosi, tatuati, intenti a sollevare pesi o pugni al sacco.
Nelle foto scattate dal personale penitenziario è quasi
sempre presente un riferimento alla divisa, come se la vita condivisa tra le
mura del carcere avesse bisogno di segnalare però una differenza palpabile, che
dia certezze: loro e noi.
Mi colpisce un’immagine: le gambe di una poliziotta, solo
le gambe: una gamba che indossa i ruvidi pantaloni della divisa e gli
scarponcini, l’altra stretta in fuseaux neri e scarpe tacco dodici.
In una delle sale, un video scorre ininterrotto: sono
interviste. Le parole di detenuti e detenute mostrano una umanità straziante e
straziata, la rottura dolorosa con gli affetti lasciati fuori dalle mura, la
speranza di un domani in cui sarà loro possibile prendere una strada lontana
dal crimine; speranza che cozza con la fragilità di cui sono portatori e la
diffidenza, quando non l’ostilità, che sanno di incontrare fuori.
Le vetrate delle sale si affacciano sui giardini, tra
statue e bimbi; fuori, il sole e lo scalpiccio delle persone libere di andare e
venire. Libere.
PAC via Palestro 14
09.10.2022 – 06.11.2022

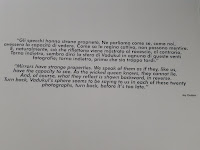



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
